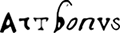Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto
Nell'area antistante l'ex chiesa abbaziale di Santa Maria della Vangadizza (secc. X-XVIII), nell'attuale Piazza Vangadizza, sono collocate due arche sepolcrali poste in posizione sopraelevata e sorrette da quattro pilastri in pietra. L'arca di sinistra, rispetto al portale della chiesa, è un monumento funebre in marmo bianco di notevole pregio. Appartenente al modello "a cassapanca", l'arca è ornata sulla faccia principale da due croci a bracci espansi e da una ghirlanda centrale. Il motivo decorativo, di chiaro stampo cristiano, rimanda alla produzione ravennate del VI secolo, mentre il coperchio del tipo "a capanna" ha un motivo decorativo su entrambi i lati caratterizzato da sei archi sostenuti da semicolonne con capitelli corinzi. Due croci a bracci espansi impreziosiscono i lati corti del coperchio. Acroteri in forma di protomi femminili caratterizzano i quattro angoli del coperchio. L'arca di destra è in marmo rosso di Verona appartenente al modello "a cassapanca". La base è priva di decori e iscrizioni, mentre il coperchio sembra essere stato abbozzato nelle decorazioni così come nelle protomi. L'arca sembra essere composita e non il frutto di un unico monumento funebre. Le arche sono probabilmente sarcofagi di epoca romana o paleocristiana reimpiegati e modificati in fasi storiche successive e utilizzati con grande probabilità nel corso dei secoli per sepolture di importanti personalità. La presenza di arche funerarie di tipologia romana è in accordo con la presenza nell'area sottostante dell'attuale Piazza Vangadizza e nel sedime del complesso abbaziale di un'area cimiteriale medievale, utilizzata probabilmente già in epoca tardoantica e romana e di numerosi manufatti a carattere funerario di età romana presenti in Abbazia. L'ipotesi che le arche possano essere di epoca più recente non deve comunque essere esclusa, in quanto in epoca altomedievale, tra il Veneto e il Ravennate, era diffusa la pratica di costruire arche sepolcrali su modelli del VI secolo.
L'Abbazia della Vangadizza è stata fondata e ampliata da altissimi funzionari dell'aristocrazia del Regno Italico del X secolo, come i marchesi Almerico II e Ugo di Tuscia, divenuta nell'XI secolo centro di controllo obertengo in area veneta. Sulla base delle fonti storico-documentali è possibile formulare delle ipotesi su chi possa essere stato sepolto al loro interno. L'ipotesi più probabile è che le arche siano stati i sepolcri di Adalberto Azzo II (+ 1097), appartenente alla potente famiglia nobiliare degli Obertenghi e primo marchese d'Este, e di Azzo VI (1170-1212), suo pronipote, marchese d'Este e signore di Ferrara, deposti assieme alle rispettive mogli: Cunegonda dei Welfen (1020-1057) e Alice di Chatillon (1181-1235). La dinastia degli Obertenghi a partire dal XII secolo si divise dando origine a diversi gruppi dinastici, dai quali nel corso dei secoli si arrivò alla casata degli Hannover che oggi risulta proseguire nell'attuale casa regnante inglese dei Windsor.
Informazioni sullo stato della conservazione
Il bene si trova in buone condizioni conservative. Tuttavia essendo materiale lapideo collocato in spazi esterni ed essendo soggetto quindi a umidità, precipitazioni e inquinamento atmosferico, presenta una patina sulla superficie.
Informazioni sulla fruizione e orari di apertura
Essendo collocate in una piazza pubblica, le arche sono fruibili sempre.