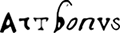Descrizione di carattere storico artistico relativa all’oggetto
La prima pietra della chiesa di S. Giuseppe fu posta nel 1519 all'interno di un ampio progetto, promosso dalla Repubblica di Venezia e dai governatori di Brescia, per dare una nuova sede al Convento dei Francescani Osservanti, dopo che i loro precedenti conventi vennero distrutti con la creazione della grande spianata attorno alla città. Tra questa data ed il 1541 il convento era quasi completato, tranne il terzo chiostro, o chiostro maggiore, che fu terminato nel 1610.
Nel 1810, in seguito ale occupazioni Napoleoniche, l’Ordine dei Minori fu abolito e il complesso passò in proprietà del Demanio. Nel corso dell'800 il chiostro minore e una parte del chiostro medio furono acquistati dalla Fabbriceria della Parroccchia dei Ss. Faustino e Giovita. Nel 1973, il terzo chiostro passò di proprietà alla Diocesi di Brescia, che volle destinarlo a sede del Museo Diocesano di Arte Sacra. Rimangono di proprietà del Demanio storico-artistico la chiesa e gran parte del chiostro medio.
Si tratta di una delle prima chiese ad impostazione rinascimentale sorte a Brescia, già a partire dall'artistica facciata, la quale risulta quasi schiacciata dalle vicine case del quartiere medievale. I tre portali sono del 1549, opera dello scultore Stefano Lamberti (1482-1538)e al di sopra vi è un ampio rosone. Sulla sommità svettano dei pinnacoli a lanterna in cotto, tipici della tradizione gotica lombarda.
L’interno è estremamente ampio - una delle maggiori chiese della città per dimensioni - ed è diviso in 3 navate senza transetto e con 10 cappelle per lato.
La navata centrale, più alta, è coperta da una volta a botte decorata da un motivo geometrico a riquadri tipicamente rinascimentale, attribuito a Stefano Rizzi, maestro del Romanino, con la collaborazione di Giovanni Antonio dei Fedeli. Alla stesa mano si attribuisce il grandioso affresco del Cristo Pantocratore con sullo sfondo la skyline della città di Brescia. Le navate laterali sono invece coperte da volte a crociera gotiche, con i costoloni e le chiavi di volta decorati.
Il presbiterio è molto profondo e sopraelevato per poter sormontare un vicolo privato. Sotto di esso si apre la cripta, definita da tre arcate a colonne con capitelli di reimpiego. Gli affreschi, opera di Sante Cattaneo (1739-1819) raffigurano i santi Rocco e Ursicino, vescovo di Brescia le cui ossa sono conservate sotto l’altare della cripta.
La chiesa custodisce uno stupendo organo Antegnati, opera di Graziadio (1523?-entro il 1590) e del figlio Costanzo (1549-1624) del 1581. Un tempo la chiesa custodiva preziosi dipinti del Romanino e del Moretto, oggi presso il Museo diocesano e la Pinacoteca Martinengo.
La chiesa di San Giuseppe divenne la “Chiesa dei Paratici”, cioè delle corporazioni di mercanti e artigiani. Varie corporazioni ottennero nel corso del tempo la dedicazione degli altari al proprio santo patrono.
Il primo e secondo chiostro - così come la bella sacristia - sono riccamente affrescati.
Informazioni sullo stato della conservazione
San Giuseppe è da sempre nel cuore dei Bresciani. Già nel secolo scorso sono stati commissionati progetti di ristrutturazione e restauro. Nel 1975 viene portato a termine il restauro del chiostro minore o della foresteria. Il chiostro medio, subisce una ristrutturazione negli anni 1970/1973. Negli anni successivi vieni restaurato il chiostro maggiore, che diviene sede del Museo Diocesano di Arte Sacra. A partire dal 1979 si avviò un restauro che riportò a fioritura le antiche decorazioni a fresco della volta centrale e di quelle laterali, dei rosoni, dei sottarchi e degli estradossi della chiesa. Nel 2018 sono stati effettuati lavori di consolidamento dei pinnacoli in cotto posti in sommità della facciata ed interventi alle grondaie per riparare a disfunzioni che causavano infiltrazioni.
Ad oggi risultano particolarmente bisognosi di cura i seguenti elementi:
1) gli importanti dipinti a fresco dei chiostri minore e medio, che risultano particolarmente degradati ed a rischio di andare perduti, nonché dell'affresco in Sacristia;
2) le grandi finestre sia della chiesa che della sacristia, logorate dal tempo e dagli agenti atmosferici
3) il magnifico organo Antegnati, del quale già da anni si paventa la necessità di un completo restauro
4) le coperture a volta dei portici, necessitanti di consolidamento statico e le coperture di tutti i tetti abbisognano di una pulitura.
Risulta necessario anche garantire una migliore fruibilità del complesso, con un ripensamento complessivo della illuminazione, in alcuni punti estremamente carente se non assente.
Informazioni sulla fruizione e orari di apertura
1) La chiesa è aperta dal lunedì al sabato, ore 8.30-17.30 e la domenica, ore 9.00-12.00.
2) i chiostri minore e medio, sono accessibili con visite guidate su prenotazione.