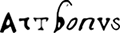Attività principali dell'istituzione
La storia dell’Associazione Culturale Altoliventina ha inizio a Prata di Pordenone nel 1971, con la fondazione di un coro chiamato Coro Tre Cime, dedicato ai cosiddetti “canti di montagna”. Inizialmente composto da sole voci maschili, il coro diventa misto nel 1976.
Fin dai primi anni, all’attività concertistica si affianca l’organizzazione di eventi musicali: dapprima le tradizionali rassegne corali, poi concerti d’organo e, infine, appuntamenti di musica da camera. Le esibizioni si tengono inizialmente a Prata, per poi estendersi a Pasiano e all’intero territorio altoliventino.
Nel 1987 il coro cambia nome, diventando Coro XX Secolo, segnando anche un’evoluzione del repertorio verso la polifonia classica e la musica corale dell’Ottocento e del Novecento.
Nel 1990 nasce l’Associazione Culturale Musicale XX Secolo, con l’obiettivo di ampliare l’attività musicale su tutto il territorio altoliventino. Vengono così avviate due stagioni concertistiche: una organistica e una dedicata alla musica da camera, ospitate nelle chiese e nelle ville dell’Altolivenza. Le due stagioni si fonderanno successivamente, dando vita all’Altolivenzafestival.
Nel 1994, dopo alcuni anni di corsi propedeutici, viene fondata la Scuola di Musica. Tre anni dopo, nel 1997, il coro cessa di esistere, ma l’Associazione, ormai una realtà solida e riconosciuta, prosegue la propria attività.
Nel 2001 l’Associazione assume il nome di Associazione Culturale Altoliventina XX Secolo, a testimonianza sia dell’ampliamento delle sue attività a tutti gli ambiti culturali, sia del suo radicamento nel territorio dell’Alto Livenza. Inizia a promuovere anche eventi teatrali; vengono avviati diversi progetti per la valorizzazione del territorio e prende avvio un’intensa attività editoriale, con la fondazione della casa editrice Altoliventina Editrice.
Nel 2008 entra a farne parte la compagnia teatrale Il Bazar degli Strambi. Nel 2014 si aggiunge il Circolo Fotografico RIFLESSI e, successivamente, verrà avviato il progettoIl Giardino dei Saperi, dedicato alla formazione degli adulti e alla condivisione del tempo libero.
Con la modifica dello statuto, nel 2022 l’Associazione assume l’attuale denominazione: Associazione Culturale Altoliventina aps.