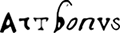Attività principali dell'istituzione
Il complesso museale Santa Maria della Scala, antico xenodochio e ospedale sulla via Francigena, conserva testimonianze di mille anni di storia, propria e della città, con un percorso che parte dall’età etrusca e romana, attraversa il Medioevo e arriva fino al contemporaneo. Diventato museo dopo un concorso di idee che ha visto lo studio Canali protagonista del cambio d’abito, oggi esso si sviluppa su vari livelli; al piano terra (IV livello) è possibile cogliere appieno quella che è stata la sua funzione primaria nel tempo, cioè dare ospitalità e cure a stranieri e pellegrini in viaggio fino a Roma e assistenza a poveri e bambini abbandonati.
Iconiche in tal senso sono: la Sala del Pellegrinaio, con gli affreschi del Quattrocento di Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta, Domenico di Bartolo e Priamo della Quercia che raffigurano le missioni dell’ospedale e la vita quotidiana dell’epoca, la Sagrestia Vecchia, affrescata anch’essa da Vecchietta, la Cappella del Manto e la Chiesa della Santissima Annunziata, con lo splendido Cristo in bronzo sempre di Vecchietta.
Il III livello si apre nella Corticella, vero e proprio snodo dei percorsi del Santa Maria, sulla quale si affaccia il fienile medievale che accoglie le statue originali scolpite da Jacopo della Quercia per Fonte Gaia, la fontana di Piazza del Campo. Qui si trovano anche il granaio medievale, le sedi di due confraternite e alcuni ambienti/magazzini. Il percorso continua nei livelli più bassi, veri e propri spazi scavati nell'arenaria, dove sono allestiti il Museo Archeologico Nazionale e la sezione "Siena: racconto della città dalle origini al Medioevo". Suggestiva anche la strada interna, oggi parte del percorso museale, ma anticamente vera e propria via cittadina inglobata e soffittata piano piano dall’ospedale durante la sua espansione.
Completano l’edificio altri livelli (V-VI-VII palazzo Squarcialupi) che ospitano la biblioteca-fototeca Giuliano Briganti, un’area espositiva per mostre temporanee e il centro convegni.
È responsabile della gestione del bene con l’obiettivo di integrarlo nel sistema culturale locale, nazionale e internazionale, facendone un punto di riferimento nel benessere per le attività artistiche e culturali, la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, fondata nel 2021.
La Fondazione organizza, nei settori scientifici di competenza, mostre, eventi culturali, spettacoli, festival, manifestazioni, convegni, incontri e scambi culturali, nonché studi, ricerche, iniziative pubblicazioni scientifico-culturali, attività didattiche e divulgative, tirocini, corsi di formazione anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private del territorio, nazionali ed internazionali. Stimola e sostiene, inoltre, l'innovazione culturale, l'inclusione, l'accessibilità e la creatività con attinenza alla storia e alla tradizione dell'antico Ospedale, favorendo e facilitando il diritto alla cultura e la partecipazione di tutti i cittadini, promuovendo la crescita di una città creativa e interculturale.