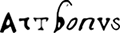Attività principali dell'istituzione
Fondata nel 1994, la Fondazione Academia Montis Regalis è un’istituzione piemontese di riferimento nella diffusione e valorizzazione della musica antica. L’omonima orchestra barocca e classica promuove il repertorio sei-settecentesco secondo criteri filologici, utilizzando strumenti originali ed avvalendosi fin dall’inizio della collaborazione con i maggiori specialisti internazionali come Ton Koopman, Jordi Savall, Christopher Hogwood, Reinhard Goebel, Monica Huggett, Enrico Gatti, Alessandro De Marchi ed Enrico Onofri. Nel corso degli anni, l’Orchestra ha intrapreso importanti collaborazioni discografiche (Opus 111, Hyperion, Sony Classic, Naive) e ha preso parte a festival e stagioni concertistiche di prestigio in Italia e all’estero, tra cui Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Festival Mi.To, Innsbrucker Festwochen, Philharmonie di Parigi, Festival di Salisburgo, Teatro degli ChampsÉlysées di Parigi, Wigmore Hall di Londra, Festival di Vancouver e di Halle. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, come il Diapason d’Or, il Choc Musique e il Premio Abbiati. Tra i progetti di rilievo si annovera la partecipazione alla Vivaldi Edition con l’incisione dell’opera omnia vivaldiana custodita alla Biblioteca Nazionale di Torino. Oltre all’attività orchestrale, l’Academia Montis Regalis promuove ensemble cameristici, masterclass e produzioni operistiche, con un’attenzione particolare ai giovani talenti e alla ricerca musicologica. Dopo la direzione di Alessandro De Marchi ed Enrico Onofri, dall’autunno 2024 l’orchestra si avvale della direzione musicale di Chiara Cattani. La Fondazione, attraverso un impegno costante, continua a diffondere la cultura musicale antica con passione, rigore filologico e apertura internazionale, contribuendo a mantenere viva la tradizione esecutiva storicamente informata.